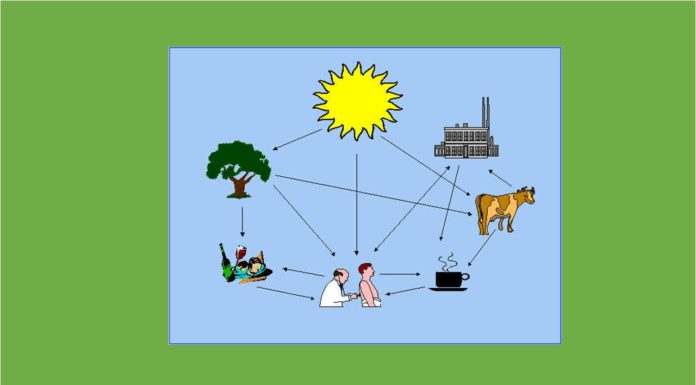Si sarebbe dovuta insediare il 1° novembre la nuova Commissione europea a guida von der Leyen e invece Jean-Claude Juncker e compagni sono stati chiamati a un mese di inattesi “straordinari”. Quella che entra ufficialmente in carica oggi è una squadra che ha incontrato non pochi ostacoli nella fase di messa a punto e che ha ottenuto solo mercoledì scorso la fiducia dell’Europarlamento, sei mesi dopo le elezioni del 26 maggio. 461 favorevoli, 157 contrari e 89 astenuti l’esito del voto in plenaria, più di quanto raccolto dallo stesso Juncker nel 2014. «Non ci può essere giorno migliore per iniziare a lavorare: siamo i custodi dei trattati e dello spirito di Lisbona – sono state le prime parole da Presidente della 61enne tedesca in riferimento all’anniversario dell’entrata in vigore, proprio il 1° dicembre 2009, dell’accordo firmato nella capitale portoghese – perché L’Europa è un tesoro da salvare».
La prima commissione guidata da una donna (12 in tutto le quote rosa, il 44% del totale) non nasce però sotto i migliori auspici: il 26 settembre il comitato giuridico del Parlamento ha respinto, durante l’esame preliminare sul conflitto d’interesse, la romena Rovana Plumb e l’ungherese László Trócsányi, candidati commissari rispettivamente ai Trasporti e alle Politiche di vicinato e allargamento. Il posto di quest’ultimo è stato preso da Olivér Várhelyi, mentre la casella dei Trasporti è stata a lungo vacante a causa della concomitante crisi di governo in Romania e solo il 6 novembre Ursula von der Leyen ha potuto annunciare la candidatura della popolare Adina-Ioana Vălean. Nel frattempo anche la macroniana Sylvie Goulard, candidata al Mercato interno, è stata rimpiazzata dall’ex ministro di Chirac Thierry Breton. Per non parlare degli strascichi che anche in questo caso ha avuto la Brexit.

Il premier Boris Johnson ad agosto aveva annunciato che non avrebbe rivendicato nessun commissario europeo per il proprio paese, visto che il giorno previsto per l’insediamento della nuova Commissione, il 1° novembre appunto, il Regno Unito sarebbe già dovuto essere fuori dall’Ue. Peccato che nessuna delle due scadenze sia stata rispettata: anche la Brexit infatti, com’è noto, è stata ulteriormente rinviata al 31 gennaio 2020. Tra le condizioni poste per il nuovo rinvio – il terzo in meno di un anno – l’impegno a nominare un nuovo commissario pro tempore prima delle elezioni politiche del 12 dicembre. Impegno puntualmente disatteso, tanto che due settimane fa la Commissione uscente si è vista costretta ad avviare una procedura d’infrazione per mancato rispetto degli obblighi previsti dai trattati. Un cortocircuito politico, fatto di ritardi e indecisioni, ai limiti del grottesco.
«Dieci anni fa i nostri predecessori ancora discutevano se l’Europa dovesse avere una bandiera e un inno – ha ricordato la von der Leyen nel corso delle celebrazioni, stamattina a Bruxelles, per i dieci anni dei trattati di Lisbona – ma in questi dieci anni milioni di persone sono scesi in strada sventolando la nostra bandiera». Una lettura ottimistica che sembra dimenticare l’altro lato della medaglia: è stato proprio l’ultimo decennio a mostrare il lato oscuro dell’Unione, alle prese con una profondissima crisi sistemica, culminata da una parte con l’intervento della Trojka in Grecia a scongiurare il rischio-default e dall’altra con l’ormai famigerato voto britannico del 23 giugno 2016. Il cammino dell’integrazione europea è sempre stato tortuoso e complicato ma mai prima d’allora era accaduto che uno Stato membro finisse sull’orlo del fallimento né che decidesse di abbandonare la nave.

Tra i ritardi che rischiano di minare il futuro dell’Ue spicca quello relativo a un vero bilancio unico dell’Eurozona, progetto che garantirebbe margini per mettere in campo una politica di crescita comune ma che rimane incagliato attorno al principio del risk-sharing. Sono molti, non solo in Nord Europa, gli stati gelosi della propria autonomia fiscale e di bilancio, anche se la neo-presidente Christine Lagarde, che il 1° novembre – lei sì, in tempo sulla tabella di marcia – ha preso il posto dell’italiano Mario Draghi alla guida della Banca centrale, s’è affrettata a rilanciare: «le politiche a favore della crescita – ha dichiarato – devono passare da un bilancio forte dell’Eurozona, anche attraverso l’emissione di eurobond che andrebbero anche a ricollocare parte dei titoli di stato oggi nel portafoglio della Bce». Sfida subito raccolta dalla von der Leyen, in un tandem femminile che proverà a invertire la rotta.
Nella prima intervista concessa dopo aver incassato la fiducia, l’ex ministra del Lavoro e della Difesa di Angela Merkel ha fatto notare come l’attuale bilancio, in scadenza nel 2021, sia stato messo a punto nel 2012, «quando la Russia non aveva ancora annesso la Crimea, la parola Daesh non era ancora nota, la destabilizzazione dell’Africa non era così grave, il tema del cambiamento climatico non era ancora in cima all’agenda e iniziavamo solo a capire cosa avrebbe significato la rivoluzione digitale». Un invito a dare al prossimo, valido per il settennio 2021-2028, una «struttura diversa, perché il mondo è cambiato». Cambio di paradigma auspicato anche sull’immigrazione: sulla tanto discussa (e mai approvata) riforma di Dublino la von der Leyen è fiduciosa che si riesca a presentare un pacchetto onnicomprensivo «tra il primo e il secondo trimestre del 2020». Rinvii permettendo…