Abbiamo una responsabilità permanente per i crimini del nazionalsocialismo, per le vittime della seconda guerra mondiale e, anzitutto, anche per l’Olocausto. Dobbiamo dire chiaramente, generazione dopo generazione, e dobbiamo dirlo ancora una volta con coraggio, il coraggio civile: ognuno, individualmente, può impedire che il razzismo e l’antisemitismo abbiano altre possibilità. Noi affrontiamo la nostra storia, non occultiamo niente, non respingiamo niente. Dobbiamo confrontarci con questo per assicurarci di essere in futuro un partner buono e degno di fede
Angela Merkel, il giorno della Memoria del 2013
Il fascismo fu l’unica esperienza contemporanea che ebbe un progetto unitario e autoritario di trasformazione della società, delle mentalità, dei ruoli di genere e dei compiti assegnati alle generazioni e all’individuo perfino nella sua sfera privata.
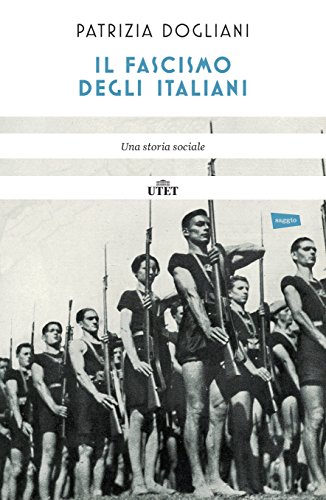
Il tema del consenso durante in Ventennio fascista resta, ancora oggi, scomodo e poco frequentato. Il libro della storica Patrizia Dogliani, Il fascismo degli italiani, edito da UTET nel 2014, si propone di restituire un ritratto della società italiana durante il Ventennio, affiancando alla nutrita mole di studi sulla storia culturale e sull’ideologia del fascismo, una prospettiva nuova, che privilegia la storia sociale. La tesi principale è che il fascismo, nonostante la violenza della sua azione e la pervasività della propaganda, non sia realmente riuscito a modificare l’assetto socio-culturale italiano, né ad interrompere tendenze già in atto nella società italiana. Lo stato sociale era uno dei cavalli di battaglia del regime, che non riuscì però a strutturare una cittadinanza sociale, perché coloro che non si adeguavano alla visione di società proposta venivano esclusi; il fascismo creò uno stato paternalista e clientelare; nazionalizzò gli italiani più e meglio di quanto aveva precedentemente fatto lo stato liberale, con un’ideologia nazionalista che degenerò, però, in politiche e pratiche razziste e xenofobe. Non sempre il regime ebbe successo nelle sue politiche sociali: per esempio, pur incentivando sia l’incremento demografico che l’occupazione nelle campagne, non riuscì a impedire alla popolazione italiana di decrescere e di abbandonare le zone montane o rurali per spingersi verso pianure e città.
Da almeno due decenni i più innovativi lavori sul fascismo si concentrano su colonialismo, razzismo, antisemitismo, antislavismo, sessismo, omofobia, in breve, su quella politica di discriminazione e odio dell’Altro a lungo messa in secondo piano anche da molti storici, più attenti allo scontro politico e ideologico tra fascisti e antifascisti militanti. Il fascismo fomentò pregiudizi e odio: quegli stessi italiani che si consideravano e che hanno continuato a considerarsi “brava gente”, non sono solo stati vittime della violenza della dittatura fascista, ma si sono, in molti casi, trovati ad essere colpevoli di sopraffazione verso persone che il regime considerava “inferiori”, meno degne, o a sostenere l’esportazione oltre i confini nazionali di quelle stesse pratiche persecutorie e liberticide. Un paradossale, circolare, scambio tra figura della vittima e del carnefice.
Un’accettazione passiva della forza che origina sin dall’atto di nascita del regime: fu proprio la Marcia su Roma a rendere palese «una volta di più, la forza dei fascisti, l’incapacità e la non volontà dello Stato di reagire e di far valere alcuni principi fondamentali della sua esistenza, tra i quali la libertà di stampa, la libertà di espressione e di associazione, ma anche il monopolio della forza».

Uno dei fattori che ha spinto a postdatare la nascita del regime fascista dalla fine del 1922 al 1925 è stato l’inizio della legalizzazione della repressione. La creazione dello Stato fascista comportò, fin dai primi anni del regime, la repressione di ogni forma di opposizione attiva e organizzata. Nel settembre 1925 l’allora segretario del PNF, Roberto Farinacci, semplificava con rozzezza ma anche con molta chiarezza un concetto: «In Italia nessuno potrà essere antifascista perché l’antifascista non può essere italiano». Azione e reazione marciano congiunte: prima della crisi conseguente all’assassinio di Giacomo Matteotti, non si può propriamente parlare di antifascismo militante, quanto piuttosto di forme di opposizione parlamentare ed extraparlamentare all’operato e alla crescita del potere del fascismo. E’ infatti ormai appurato come la più compatta e autorevole opposizione antifascista, almeno fino al 1926, sia di carattere intellettuale, condotta da uomini e donne la cui formazione maturò per lo più in piena età liberale e giolittiana, ma comunque fortemente legata all’esperienza risorgimentale e ai suoi ideali. La pubblicazione del Manifesto degli intellettuali antifascisti sulle pagine de Il Mondo e de Il Popolo il 1° maggio 1925 è la dimostrazione di un impegno diretto e controcorrente – rispetto a quegli intellettuali che tacevano o che erano sostanzialmente conniventi con il fascismo – capace di percepire fino in fondo la deriva autoritaria fascista, diversamente dal mondo partitico, . L’iniziale sottovalutazione del fenomeno da parte socialista e liberale accompagnata da uno scarso consenso intorno all’antifascismo senza compromessi di Matteotti produssero una risposta inadeguata e fuori tempo massimo, che agevolò senz’altro le mosse del regime.
La promulgazione delle cosiddette leggi fascistissime diede il via all’esodo di dirigenti politici, sulla base di due assunzioni: il pericolo per la propria incolumità fisica privata di ogni forma di protezione legale; l’idea di una battaglia che appariva definitivamente persa. Si pensava fosse quindi necessaria una pausa di riflessione, una riorganizzazione delle forze e delle volontà contrarie al fascismo. Fu chiamato “fuoriuscitismo” l’esodo verso altri paesi dei quadri dirigenti e di alcuni intellettuali che avevano rappresentato l’opposizione nella seconda metà del 1924. Alcuni di essi morirono a seguito di aggressioni subite: tra questi, il giovane liberale Piero Gobetti, a nemmeno venticinque anni, a Parigi, e il principale esponente dell’Unione democratica nazionale, Giovanni Amendola, poco più che quarantenne, a Cannes.

La legge per la difesa dello Stato entrava in vigore nel dicembre 1926 e reintroduceva la pena di morte (abolita dal Codice Zanardelli nel 1889). Tra il 1927 e il 1943 il Tribunale speciale inquisì circa 21 000 persone e inflisse 4 596 condanne a 5 619 imputati, in grande maggioranza operai e artigiani, seguiti da contadini e da professionisti, studenti, impiegati nel terziario; di cui 118 a morte, (117 uomini e una donna, Laura D’Oriano, condannata per spionaggio nel 1943 e unica giustiziata femminile della storia d’Italia eccezion fatta per il periodo 1943-1945).
Contemporaneamente alla politica di repressione, cresceva e maturava dal movimento fascista un Partito nazionale. Esso non può essere visto come un corpo omogeneo e invariabile, bensì come un’istituzione sottoposta a una lenta e incessante metamorfosi, adattata ai mutamenti strutturali intervenuti nello Stato e nella società italiana, oltre che alle dinamiche di potere interne al gruppo dirigente fascista
Una serie di leggi, dette “fascistissime”, accentuarono quindi l’esodo verso l’estero, e suggerirono nel contempo l’attività interna illegale del Partito comunista e la nascita di nuovi gruppi d’opposizione, in particolare quelli di ispirazione socialista, repubblicana e democratica, espressione essenzialmente di intellettuali e di professionisti che si erano raccolti in circoli e gruppi cospirativi nelle città universitarie di Firenze, Milano e Torino. Alcuni di loro nel 1929 avrebbero dato vita alla formazione Giustizia e Libertà.

Il concetto di nazione coniato dal fascismo appare complesso e composto da elementi eterogenei, forte però di un processo di esclusione di tutto ciò che nella storia e nella società veniva considerato un corpo estraneo e non riconducibile all’idea di nazione forte, omogenea, atta ad affermare un primato ideale e storico dell’Italia sulle altre nazioni e su altri popoli. I corpi estranei erano le forme di esterofilia, i prodotti di culture straniere, gli uomini e le idee che non condividevano la convinzione che il fascismo fosse l’unica e più completa fase dell’evoluzione storica e statuale dell’Italia: che il fascismo fosse la nazione italiana. Il fascismo impoverì in Italia l’idea di nazione, privandola dei nessi con la libertà, l’umanità, l’eguaglianza tra stati e tra cittadini. Anche il termine antifascista assumeva molteplici valenze, non era solo l’oppositore politico ma chiunque non si integrasse o non venisse considerato assimilabile alla società ridisegnata dal regime: allogeni, sudditi coloniali, ebrei e minoranze religiose, omosessuali.
La popolarità del regime e delle sue politiche era vera? C’è stato un momento in cui gli italiani credevano alla politica di potenza del regime? La retorica fascista aveva preparato la popolazione italiana alla guerra, almeno così si credeva. Le grandi adunate, l’esasperazione della preparazione fisica e militare, il simbolico richiamo alla vittoria del
1918 come suggello e spinta per ogni futura operazione.
La crescita della popolarità del regime fu legata alla dualità delle opere messe in campo e delle azioni di propaganda. Da un lato la sua natura sociale che gli permetteva di annoverare, di riforma in riforma, una serie di iniziative ben viste dal popolo italiano, dall’altro una macchina di propaganda efficiente e ben tarata che poteva inoltre giovare
dell’assenza di un’opposizione, creavano un circolo virtuoso in cui queste due nature finivano per fondersi: difficile, ad esempio, stabilire univocamente se le grandi opere di bonifica o le imprese coloniali avessero generato più approvazione per i risultati prodotti o più soddisfazione per l’elargizione di terre; impossibile calcolare a posteriori in che misura il popolo italiano si recava spontaneamente nelle piazze o veniva invitato da lettere della prefettura di residenza. Il consenso generava consenso.
La costruzione del consenso si attuava attraverso le numerose istituzioni scolastiche e di partito che avevano come compito la creazione dell’uomo nuovo, rigenerato dalla lotta. Le pratiche della propaganda trovavano ampia e diffusa attuazione nelle numerose adunate, ma anche nella silenziosa e fatale azione della censura. La materia del controllo delle “idee” faceva capo al ministero dell’Interno, che fu retto da Mussolini dal 1926 al 1943. Nel 1937 fu creato un nuovo ministero per la gestione della propaganda di regime che doveva aiutare le istituzioni nella creazione dell’italiano nuovo: il guerriero.
All’interno della galassia di organizzazioni del Partito fascista, fu consentita solamente l’Azione Cattolica (sciolta dal 1928 al 1931), che per molti anni costituì il rifugio di chi non voleva sottomettersi alle direttive e alla conformazione delle coscienze che il regime stava attuando.






































