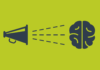Fino a circa venti anni fa la questione israelo-palestinese occupava una posizione di assoluto rilievo nelle agende politiche di gran parte dei governi mediorientali e delle superpotenze mondiali. La necessità di trovare una soluzione ad una crisi iniziata all’indomani della fine del secondo conflitto mondiale e che nell’immaginario collettivo rappresentava il conflitto per eccellenza, in grado di polarizzare e dividere l’opinione pubblica ma allo stesso tempo di compattare (almeno formalmente) l’intero mondo arabo nel comune sostegno alla causa palestinese, era vista come un’assoluta priorità da gran parte della comunità internazionale.
La firma degli “Accordi di Abramo” da parte di Israele, Emirati Arabi Uniti e Bahrein, avvenuta lo scorso 15 settembre alla Casa Bianca con la presenza di Donald Trump, costituisce invece il coronamento di una tendenza, avviatasi con lo scoppio delle primavere arabe, che ha portato la decennale contesa tra palestinesi e israeliani ad occupare un ruolo sempre più marginale nello scenario mediorientale.

(fonte globalist)
L’incapacità della comunità internazionale di trovare una soluzione al problema, le continue divisioni interne al fronte palestinese e il (naturale?) prevalere delle considerazioni economiche e geopolitiche su quelle di carattere umanitario sono solamente alcuni dei fattori che hanno contribuito a mettere le basi per il raggiungimento dell’intesa con cui le due monarchie del Golfo si vanno ad aggiungere a Egitto e Giordania nell’elenco dei paesi arabi che hanno intrapreso relazioni diplomatiche con Israele. Non è da escludere, tra l’altro, che altri paesi possano fare nei prossimi tempi la stessa mossa (Sudan su tutti). E’ improbabile, per il momento, che all’elenco possa aggiungersi l’Arabia Saudita, ma è altresì chiaro come le intese appena raggiunte abbiano il pieno consenso di quella che rimane ancora oggi la monarchia del Golfo di gran lunga più influente (il controllo saudita nei confronti del Bahrein, in particolare, è pressoché totale). Secondo il comandante del Mossad Yossi Cohen, Arabia Saudita e Israele intrattengono relazioni pacifiche in via non ufficiale, e l’auspicio è che un accordo di normalizzazione possa essere stipulato con altri paesi in futuro e che la nuova intesa possa rafforzare l’asse anti-Iran.
A differenza di Egitto e Giordania, Bahrein e Emirati Arabi Uniti non sono mai stati realmente in guerra con Israele e il raggiungimento dell’intesa (che fa seguito ad anni di avvicinamento diplomatico tra Israele e le monarchie del Golfo, alla presentazione del ”Accordo del Secolo” di Trump e ai proclami di Netanyahu sull’annessione dei territori in Cisgiordania) apre una nuova fase per gli equilibri in Medio Oriente in cui, paradossalmente, i principali sostenitori della causa palestinese sono due paesi non arabi: Turchia e Iran.
Formalmente, la firma degli accordi viene subordinata al momentaneo accantonamento delle mire espansionistiche di Netanyahu in Cisgiordania, ma lo stesso premier israeliano non ha tardato a sottolineare che i piani di annessione restano una priorità della sua agenda politica. Il raggiungimento di un accordo del genere rappresenta un tradimento nei confronti della causa palestinese, alla luce di quello che era stato il comune impegno, sottoscritto dai paesi della Lega Araba nel 2002, a vincolare una qualunque intesa con Israele al riconoscimento di un’entità statale e alla fine dell’occupazione sionista.

La reazione agli accordi è stata di ferma condanna. Ismail Haniyeh, leader e storico esponente di Hamas, ha dichiarato che “la storia non avrà pietà” di chi ha voltato le spalle alla causa palestinese. Il movimento islamico di resistenza (che ha recentemente intensificato il dialogo con la Russia di Vladimir Putin) ha inoltre accusato gli Stati Uniti di aver forzato la mano verso i paesi arabi e di averli costretti a tagliare i finanziamenti diretti all’Autorità nazionale, che nell’ultimo anno sono crollati di oltre l’80%. Il supporto finanziario verso l’ANP è in effetti in costante declino da diversi anni, e un’ulteriore riduzione è coincisa con l’arrivo alla Casa Bianca di Donald Trump e con la crisi petrolifera che ha colpito negli scorsi mesi le monarchie del Golfo.
L’annuncio della costruzione di 5000 nuove case per coloni in Cisgiordania non ha suscitato nessuna reazione da parte di Emirati e Bahrein, mentre ONU e comunità palestinesi hanno fatto appello al rispetto del diritto internazionale. Il silenzio dei due piccoli stati arabi di fronte alla ripresa dei piani di espansione coloniale israeliana rappresenta la riprova di come il riconoscimento diplomatico non possa considerarsi una mossa volta a frenare i tentativi di annessione sbandierati da Netanyahu ma risponda invece a precisi calcoli economici, commerciali e geopolitici. Nella giornata di martedì ha avuto luogo il primo viaggio ufficiale in Israele di diplomatici emiratini, e nel corso dell’incontro tra le controparti, a cui ha partecipato tra l’altro il segretario al tesoro americano Steven Mnuchin e che si è svolto interamente all’aeroporto Ben Gurion per via dell’emergenza Covid, sono stati siglati ulteriori accordi per il rinforzamento dei legami tra i due paesi. In particolare verranno tolte le restrizioni sui viaggi (con voli diretti tra i due paesi), è stato sancito il comune impegno a rinforzare e “modernizzare” i check-point in Cisgiordania, si è parlato di un progetto per il trasporto verso l’Europa del petrolio degli Emirati senza passare da Suez e per la prima volta è stato messo sul tavolo il tema riguardante la futura apertura delle rispettive missioni diplomatiche a Tel Aviv e Abu Dhabi.
In Bahrein, la popolazione è scesa in piazza per esprimere il proprio dissenso nei confronti della “normalizzazione”. E’ evidente come, all’interno di stati semi-assolutistici in cui il principio della rappresentanza del popolo nelle istituzioni non è neanche lontanamente tenuto in considerazione, le decisioni prese dai Capi di Stato possano raramente dirsi effettivamente espressione di una volontà popolare. Negli anni passati l’invio di aiuti militari da parte del governo saudita era stato cruciale nel sedare le rivolte della maggioranza sciita nel paese, scesa in piazza per esprimere il proprio malcontento verso una politica discriminatoria. Nelle ultime settimane, invece, le continue proteste della popolazione hanno provocato un ritardo nella firma di un vero e proprio trattato di pace tra Israele e Bahrein: al momento, l’intesa raggiunta si limita ad un impegno comune, mentre non è ancora stato formalizzato il vero e proprio accordo.

(fonte albawaba)
Proprio quello della rappresentanza costituisce per la causa palestinese uno dei principali temi da affrontare per provare a riportare sui giusti binari una situazione che al momento sembra compromessa. Gli accordi di Oslo del 1993 prevedevano, tra le altre cose, il riconoscimento da parte israeliana, del diritto palestinese all’autogoverno e la conseguente istituzione di un’Autorità Nazionale Palestinese, alla quale veniva assegnato il controllo di alcune aree, che avrebbe dovuto negoziare lo status definitivo di tutti i territori palestinesi.
I recenti sviluppi rappresentano, tuttavia, l’ennesima prova del fallimento dell’ANP, che in quasi 30 anni di storia non è stata in grado di difendere la sovranità del popolo palestinese sulle proprie terre contro i tentativi di espansione di Israele. Lo scontro politico tra le due principali fazioni politiche, Hamas e Fatah, acuitosi con la morte di Arafat e con la sorprendente vittoria di Hamas alle elezioni per il Consiglio legislativo (il Parlamento dei territori) nel gennaio del 2006, ha contribuito a definire i contorni di una situazione in cui l’Autorità Nazionale Palestinese si è consolidata come principale rappresentante del popolo palestinese, rendendo di fatto il ruolo dell’OLP totalmente marginale nell’attuale scenario politico.
A causa della forte dipendenza dal supporto internazionale e dell’incapacità di farsi effettivamente portatrice delle istanze e della volontà di larghe fasce della popolazione, tuttavia, il potere decisionale dell’ANP è pressoché nullo. E’ il momento di porsi dubbi sull’effettiva utilità istituzionale di un soggetto politico che, oltre a non essere inclusivo e rappresentativo, non è stato in grado di difendere il diritto palestinese all’autodeterminazione.

Da anni ormai le sorti del popolo palestinese dipendono in larga misura da avvenimenti esterni e da decisioni prese da soggetti terzi. L’arrivo sulla scena politica di Yasser Arafat, negli anni ’50, rispondeva proprio all’esigenza di rendere i palestinesi artefici del proprio destino e di rompere la dipendenza dalla Lega Araba che si era venuta a creare dopo la nascita di Israele. Lo spirito di rivalsa e di riscatto aveva animato la nascita di Fatah (Movimento di liberazione palestinese) nel 1959 e, solo pochi anni dopo, dell’OLP (Organizzazione per la liberazione della Palestina).
I risultati ottenuti, negli anni e con diverse modalità, non hanno effettivamente portato ad una soluzione, e una volta venuta meno la figura carismatica di Abu Ammar si erano create le condizioni perché si imponessero, come dominatori della scena politica, movimenti di ispirazione islamista come Hamas e il Movimento per la Jihad islamica.
Ma è importante, in questo momento storico, che la Palestina recuperi il legame con la propria leadership politica, che negli anni passati aveva costituito un fattore di speranza e di immedesimazione del singolo nello sforzo collettivo verso l’autodeterminazione e la sovranità. Il divario tra l’élite di potere e le fasce della popolazione negli anni si è allargata, e la partecipazione popolare alle principali decisioni è stata marginale e ininfluente. L’adozione di un nuovo e più efficace sistema di governance è un altro punto prioritario: un maggiore spazio di manovra va lasciato ai sindaci e alle autorità locali, che spesso sono le uniche istituzioni rappresentative nel quale il popolo è veramente in grado di riconoscersi.
Il recupero di un soggetto politico come l’OLP, che negli anni ’60 era riuscito a organizzare l’azione palestinese e a incanalare il supporto degli alleati arabi, darebbe nuova linfa alla causa e metterebbe le basi per un maggiore coinvolgimento di una nuova generazione di leader palestinesi. La creazione di un vero consenso, che si basi su un legame effettivo tra classe politica e cittadini, è un elemento chiave per una potenziale partenza di un OLP rinnovato e riformato.
In questa ottica, il recente raggiungimento di un’intesa tra Fatah e Hamas di un accordo per lo svolgimento delle elezioni generali (le prime dal 2006) è senz’altro un punto di partenza nelle definizione di un cammino verso un nuovo modello di rappresentanza. L’intesa, firmata in Turchia, è stata raggiunta tra i leader delle due fazioni, Mahmoud Abbas e Ismail Haniyeh, dopo giorni di frenetiche trattative e grazie alla mediazione del governo di Ankara.
Le votazioni si terranno per eleggere il presidente dell’Autorità palestinese, il suo Consiglio legislativo e per il Consiglio Nazionale (l’organo legislativo) dell’OLP. Secondo Nafiz Azzam, leader del Movimento per la Jihad islamica, l’accordo può porre le basi per la fine della fase di distruzione e divisioni inaugurata dalla firma degli accordi di Oslo nel 1993. Il movimento, tuttavia, parteciperò solamente alle elezioni del Consiglio Nazionale dell’OLP, poiché l’AP e il suo Consiglio legislativo sono prodotti degli accordi di Oslo, che il movimento non ha mai riconosciuto.
Proprio la partecipazione di tutte le fazioni ad una futura tornata elettorale per il Consiglio Nazionale è un passaggio cruciale per ripristinare la legittimità dell’OLP come soggetto rappresentativo di tutti i palestinesi, e restituire la centralità e il ruolo di guida che l’istituzione ha perso negli ultimi anni.
E’ ora, per i movimenti palestinesi, di aprire un nuovo corso politico che sia in grado di invertire la tendenza che vuole una progressiva marginalizzazione della questione nello scenario internazionale. Il recupero di una dignità politica, unita al supporto incondizionato di attori come la Turchia, deve essere il punto di partenza per rialzare la testa e ricostruire in patria le fondamenta delle proprie reti popolari. In particolare, la questione dei rifugiati palestinesi e la costruzione di un rinnovato radicamento nei campi profughi e nella diaspora sono punti essenziali di un programma che deve tenere conto degli enormi tagli voluti dall’amministrazione Trump nei confronti dell’agenzia UNRWA, che ha di recente annunciato la cessazione nell’erogazione di alcuni servizi essenziali a causa della disperata crisi finanziaria.
L’arrivo alla Casa Bianca di Donald Trump, l’eterno Benjamin Netanyahu e il tradimento delle monarchie del Golfo sembrano aver dato un colpo di grazia alla causa palestinese. Il tessuto socio-economico della Cisgiordania e della Striscia di Gaza è ormai allo stremo, e le conseguenze della crisi sanitaria dovuta alla pandemia rischiano di trascinare verso il collasso vari settori della società in cui imperversano povertà e disoccupazione. In un contesto di crisi umanitaria e emergenza sanitaria gli aiuti internazionali (con sussidi alle imprese e indennità di disoccupazione) saranno fondamentali per permettere di superare la pandemia.
La ripartenza, però, deve avvenire dall’interno e deve innanzitutto basarsi sul recupero del consenso e della rappresentanza e sul superamento delle divisioni che hanno indebolito il movimento palestinese negli ultimi decenni. Sarebbe ingenuo e vano aspettarsi che la situazione possa migliorare grazie a un avvicendamento nella guida dei principali attori internazionali ed è cruciale che la ricostruzione di un soggetto politico inclusivo che sia in grado di farsi portavoce delle istanze interne avvenga in tempi rapidi e prima che la causa palestinese venga ridotta ad un problema umanitario ed economico da tenere sotto controllo attraverso i finanziamenti arabi ed americani.